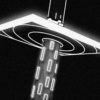La protagonista del libro è senza dubbio la complessità e il titolo stesso suggerisce che questa complessità non bisogna evitarla come cercano di fare tutti i possibili riduzionismi, ma che bisogna affrontarla così com’è.
La complessità non è solamente da intendersi come l’interazione, l’interdipendenza e l’interconnessione tra fenomeni eterogenei che appartengono al campo delle scienze naturali e delle scienze umane. Questo è ormai diventato ovvio. La complessità è una totalità che è impossibile da osservare dall’esterno, come un oggetto che giace davanti a noi, perché noi stessi facciamo parte di essa. Siamo all’interno di una complessità onni-abbracciante. Aldo Leopold diceva che non siamo noi a proteggere le foreste, ma sono le foreste a proteggere noi. La complessità è una totalità che non ha nulla al di fuori e, quindi, non permette quella distanziazione che è propria della scienza.
Per questo non può esservi una vera e propria scienza globale della complessità. Ed è forse questa la ragione per cui mi sembra che l’autore di questo libro usi con molta parsimonia e con una certa ritrosia il termine “ecologia”. Come sappiamo, l’ecologia, intesa come lo studio delle relazioni tra l’essere vivente e l’ambiente in cui vive, pretende di essere una vera e propria scienza naturale, per quanto interdisciplinare. Ma la complessità è ben più ambiziosa dell’ecosistema, perché comprende anche quei fenomeni che sono studiati dalle discipline umanistiche, quali l’economia, l’etica e la politica. Questo significa la rinuncia ad una scienza della complessità, ma non significa un abbandono della scientificità.
Ora si deve pensare ad una molteplicità di percorsi cognitivi che s’intersecano fra loro, come in una rete. Una volta scelto il filo da seguire, si può osservare con quali altri fili s’intreccia senza tuttavia riuscire a ricomprenderli tutti. Non c’è – come s’è già detto – una scienza globale della complessità. La complessità è reticolare, che però non si deve confondere con settoriale o specialistica, com’è proprio delle scienze: ogni percorso cognitivo reticolare è provvisorio, richiede continui aggiornamenti, deve essere pronto a cogliere la novità e l’emergenza, deve essere disponibile ad arricchire i dati da prendere in considerazione ed a modificare le connessioni anche in ragione di eventi inaspettati. Non si può programmare sino in fondo il percorso nella rete.
Mi sembra evidente che il libro sia pienamente consapevole di questa visione epistemologica. Questo libro è un esempio di “ecologia integrale relazionale”, per esprimerci nei termini di Papa Francesco. Ma, se non v’è una scienza globale della complessità, non per questo bisogna rinunciare a dare un’idea della molteplicità dei percorsi cognitivi e della varietà delle discipline che sono chiamate in causa. Questo libro è un illuminante esempio di come si possa ritessere e ricucire la rete secondo le finalità cognitive, sempre nel rispetto dei metodi e dei principi delle scienze di volta in volta coinvolte ma anche della loro interrelazione. Per questo opportunamente è stato evocato il ruolo delle biblioteche che, contenendo testi di discipline differenti, devono ora mostrare che la loro prossimità negli scaffali non è puramente fisica, ma racchiude una potenzialità infinita di interazioni.
Il carattere totalizzante della complessità fa sì che non ci si possa limitare alla pura e semplice spiegazione dei fenomeni osservati e neppure alla comprensione dei comportamenti umani e delle intenzioni retrostanti, perché la rete deve anche essere riparata. V’è, dunque, anche una dimensione normativa rivolta a scoraggiare da comportamenti degenerativi, ad orientare verso comportamenti riparativi di manutenzione e costruttivi e a pianificare un futuro sostenibile. E qui dalla ragione teorica passiamo alla ragion pratica, dove le soluzioni normative sono spesso molteplici e si discute di quelle più adatte, più conseguenti, più sane, più praticabili. Si richie- dono decisioni comuni per comportamenti uniformi e ciò implica anche deliberazioni politiche e nuovi stili di vita.
In conclusione, la complessità richiede scienza e sapienza, tecnica e saggezza, arte ed etica. Essa chiama a raccolta tutte le risorse umane, ma nella convinzione che la complessità ci sopravanza sempre, sia perché noi siamo parte di essa, sia perché le nostre capacità intellettuali e morali sono limitate come lo sono tutte le risorse naturali, non sono in grado di abbracciare questa totalità e di astenersi del tutto da comportamenti predatori. Con questo non voglio dire che bisogna rinunciare all’utopia, perché il vero e proprio pensiero utopico è quello che non si fa illusioni.
Ora i delicati equilibri di questa rete complessa, di cui noi facciamo parte, è minacciata dalla nostra stessa azione e già si va sfilacciando in molte sue parti. Lo possiamo facilmente constatare dai due effetti più macroscopici: il cambiamento climatico che va verso il riscaldamento globale e la perdita della biodiversità, che impoverisce la varietà degli esseri, producendo vuoti e salti nella continuità della natura. Ma non si tratta che la punta di un iceberg. Nel corso della sua lunghissima storia il sistema Terra è sempre stato in continua evoluzione, ma ora la novità è che queste mutazioni sono prodotte dall’artificio umano e non già soltanto da fattori naturali e involontari. E si parla degli effetti della rivoluzione industriale e capitalistica, di stili di vita segnati dall’ansia consumistica che spingono ad una produzione agricola devastante e a sprechi dissennati (accenno qui solo ad alcuni dei fattori di crisi esaminati nel libro). Quindi, per la prima volta nella storia geologica le sorti della Terra appaiono legate all’azione umana e, attraverso di essa, alla volontà umana, alla deliberazione, alla scelta e alla decisione umana. I credenti diranno che così si compie il disegno originario della creazione, cioè mettere la Terra nelle mani dell’uomo. Ma i non credenti obietteranno che, se così fosse, sarebbe un Dio che non agisce con saggezza, dati i limiti evidenti della natura umana.
Pertanto, la nostra era geologica è considerata come quella dell’Antropocene, perché è segnata in modo determinante dall’opera dell’uomo secondo alcuni e, secondo altri, dall’opera perturbatrice dell’uomo. Siamo entrati in un’era in cui il genere umano deve essere considerato una forza geologica, alla stessa stregua dei vulcani e dei terremoti, e al contempo come una capacità cosciente in azione. L’Antropocene ha preso il posto dell’Olocene che viene considerato come quell’era geologica in cui la Terra ha perseguito con un certo successo un suo stato di equilibrio rispettoso della biodiversità e anche favorevole al “principio antropico”, cioè a quell’insieme di condizioni che rendono possibili la sopravvivenza della specie umana sulla Terra.
Nell’Antropocene con le nostre attività e i nostri stili di vita non abbiamo cambiato solo l’ambiente che ci circonda, ma abbiamo cambiato anche noi stessi, il nostro corpo e le relazioni sociali. Il cambiamento di per sé non è cosa negativa, ma lo diviene se è di danno nei confronti della natura e delle generazioni future, come in effetti sta accadendo sotto i nostri occhi. Neppure sarebbe giustificato dal calcolo utilitaristico, dato che il nostro destino è indissolubilmente legato a quello della Terra. Il degrado della natura è inevitabilmente anche degrado dell’umano (1). C’è una comunanza di destino. D’altronde, alla fin dei conti, se consideriamo che il XX secolo è stato finora il secolo più aggressivo nei confronti della natura, queste generazioni future già danneggiate siamo noi stessi.
Questo processo tipico di un antropocentrismo possessivo, attivato dalla crescita imprenditoriale ed economica, si fonda su un paradosso: il mito di uno sviluppo infinito di un mondo finito. Questo libro insiste sui limiti delle risorse della natura e sulla fragilità e vulnerabilità dei processi biologici. Il benessere consumistico è incurante di questi limiti in quanto la sua voracità è priva di limiti.
La considerazione dell’Antropocene può avvenire da due prospettive: una di esse dal presente guarda il passato per capire le cause del problema e l’altra dal presente guarda al futuro per individuarne le possibili soluzioni. In questo libro si considera l’uno e l’altro aspetto nella convinzione, giustissima, che le due prospettive da sole sono incomplete, perché ciò che è causato dall’uomo solo dall’uomo può essere sanato. Questa è d’altronde la doppia faccia della responsabilità.
Sull’uomo grava, dunque, una duplice responsabilità, quella della causa e quella della riparazione. Si risponde alla prima con la seconda. In ogni caso siamo dentro l’antropocentri-smo, che non deve essere in linea di principio demonizzato. C’è un antropocentrismo cattivo e uno buono. Se siamo nell’Antropocene, credo che dobbiamo rassegnarci all’antropocentrismo (ma su questo argomento ci sono posizioni differenti) (2). Ritornare all’Olocene è impossibile, perché ormai il vaso di Pandora s’è aperto. Ma abbandonare comportamenti e stili di vita predatori per autolimitarsi ed autoregolarsi, essere sobri e solidali non significa rinunciare all’antropocen- trismo. Questo richiederebbe di tornare ad un tempo in cui il fattore umano non era così rilevante. C’è, dunque, un antropocentrismo predatorio e un antropocentrismo sobrio e moderato.
Il fatto è che l’ordine della natura è ora diventato dipendente da una scelta umana. Al tempo dell’Olocene non era così, l’uomo era soggetto ad un ordine fisico a cui non poteva sottrarsi. Poteva solo rifugiarsi nel regno spirituale della libertà, donde la separazione tra materia e spirito. Ma, quando la tecnica umana ha mostrato la possibilità di modificare e manipolare l’ordine della natura, allora il nostro rapporto con la natura e con la nostra stessa corporeità è divenuto un problema morale per l’umanità intera, sede di una scelta morale di carattere epocale.
Dobbiamo chiederci se vogliamo difendere e custodire la natura così come l’ha formato la sua lunga storia geologica, cioè come quell’ambiente volto ad accogliere la più grande varietà possibile degli esseri. Al contempo dobbiamo anche interrogarci se intendiamo custodire l’essere umano così come l’ha formato la sua lunga storia biologica, cioè come un essere fragile e vulnerabile, ma anche capace di migliorare con la tecnica le sue condizioni esistenziali pur sempre all’interno del paradigma dell’umanesimo ecologico. Le discussioni attuali sul post-umanesimo e transumanesimo appartengono a questo dilemma morale.
Il guaio è che, anche se dobbiamo scegliere, non abbiamo una vera e propria alternativa, perché siamo capaci di distruggere l’ordine attuale, ma non abbiamo la possibilità di costruirne un altro. La potenza manipolativa dell’uomo si deve coniugare con il fatto dell’irreversibilità dell’azione tecnologica. Siamo qui di fronte ad una doppia fragilità: la scienza non riesce a prevedere tutti i possibili effetti dell’azione tecnologica e la tecnica non è in grado di ripristinare ciò che ha distrutto. È quella che Fritiof Capra ha chiamato “l’impotenza degli esperti”: più ci inoltriamo nella manipolazione, più difficile è tornare indietro.
Ed allora il dilemma morale non è una vera e propria scelta fra alternative possibili, ma è una questione di accettazione e di riconoscimento della propria responsabilità nei confronti dell’essere. E qui si mescolano due prospettive etiche en- trambe necessarie, quella dell’utile e quella del bene in sé. L’argomento utilitaristico spesso è considerato come il più convincente: dobbiamo proteggere la natura se vogliamo salvare la nostra pelle. Ma chi è immerso nel benessere consumistico scambia i propri desideri per bisogni necessari e così finisce per errare nel calcolo delle utilità. Ben conosciamo i travisamenti dell’homo oeconomicus. Nessuno è capace di danneggiare se stesso più dell’homo oeconomicus.
Se, invece, guardiamo alla complessità nel suo insieme, come totalità, a quella complessità di cui – come s’è detto – facciamo parte, allora essa si presenta come un bene in sé o un valore intrinseco da custodire non già perché sia utile a qualcuno, ma perché è quell’insieme di legami e di relazioni che rende possibile l’esistenza del tutto. Così l’argomento utilitaristico e quello deontologico finiscono per convergere: un mondo quanto più è vario tanto più protegge gli esseri che lo abitano.
Un’altra parte del libro che ho particolarmente apprezzato riguarda quella dedicata alla proposta dei rimedi. Qui l’autore evita accuratamente tre derive in cui spesso incorrono gli ambientalisti: quella statalista, quella mercantile e quella ideologica.
La prima deriva è rappresentata dall’autoritarismo e dallo statalismo. Si pensa, infatti, che l’unico modo per combattere il degrado ambientale in modo efficace debba far ricorso ai mezzi coercitivi più convincenti e per questo ci vuole lo Stato. Non di rado i sostenitori della Deep Ecology sono di- chiaratamente antidemocratici, anche se di fatto non si conoscono regimi autoritari favorevoli ai green values. Si pensa che, se mettiamo le decisioni in mano ai privati, è ben prevedibile quella paralisi rappresentata dalla sindrome Nimby. Nessuno vuole i rifiuti tossici nel proprio giardino. Ma, se invochiamo la necessità di un cambiamento radicale dello stile di vita e una nuova cultura del produrre e del consumare, allora dobbiamo partire dal basso, cioè dalla società civile e dai comportamenti individuali. È, infatti, la somma di un’infinità di micro-azioni a devastare la natura. Ma la coercizione non genera una cultura. Per questo sono necessari comportamenti sociali guidati dal principio di sufficienza che inducano all’emulazione per la testimonianza dei loro effetti. Bisogna superare la scissione tipicamente moderna tra pubblico e privato, così come dobbiamo fare per quella tra corporeità e spiritualità. Non si può pensare di combattere il degrado ambientale nella sfera pubblica e poi inquinare allegramente in quella privata.
La seconda deriva è quella che si getta all’opposto nelle braccia dell’ economia secondo la ben nota alternanza moderna tra Stato e mercato. Il sistema messo a punto dall’economia pubblica è quello della tassazione secondo il principio per cui chi inquina ne deve pagare il prezzo, perché ha ridotto la quantità e qualità del bene disponibile per altri. Ciò significa tra l’altro che quanto più si è ricchi, tanto più si ha licenzia di inquinare a danno dei poveri che meno hanno contribuito al disastro climatico. Ma il neoliberalismo non accetta questa soluzione che accrescerebbe l’intervento fiscale dello Stato, e propone a sua volta un mercato libero di diritti d’inquinamento, in cui i permessi relativi sarebbero oggetto di negoziazione e di transazione tra le imprese e le comunità locali. Quest’orientamento viene spacciato per il modo più efficace di difendere la natura. Ma, se la complessità di per se stessa ha un valore intrinseco, è un bene in sé, allora ciò non può significare che il suo prezzo sia più alto, ma propriamente che non ha prezzo e che non è monetizzabile. Non tutto si può comprare. Non è un caso se il trionfo del neoliberalismo dagli anni 70 del secolo scorso ad oggi ha conciso con l’avvicinamento pericoloso al punto di rottura irreversibile dell’equilibrio ambientale e con la crescita espo- nenziale delle disuguaglianze. Sono molto contento che l’autore abbia individuato nel neoliberalismo una delle cause principali del disastro ecologico e abbia messo in luce la stretta relazione tra l’atteggiamento predatorio nei confronti della natura e quello nei confronti dei poveri del mondo.
La terza deriva è quella rappresentata dall’ideologia. Il libro si presenta sotto tutti gli aspetti come antiideologico, cioè come diffidente nei confronti dei programmi politici di parte. L’ecologia politica, infatti, ha visto sia un ritorno di ideologie del passato (come nell’eco-socialismo e nell’eco-anarchi- smo), sia la formulazione di nuove ideologie che si sforzano di ripensare su basi nuove tutta l’organizzazione sociale (come l’eco-femminismo o l’ecologia politica post-moderna). A questo proposito il dibattito è concentrato sulla questione dell’adeguatezza delle categorie politiche e giuridiche mo-derne e attuali nei confronti del contrasto alla crisi ecologica. Ma queste categorie non si cambiano a tavolino. Esse derivano dal cambiamento degli stili di vita personale e sociale nella misura in cui si diffondono nel costume e nelle consuetudini di vita. Se l’opera degli intellettuali non vuole essere simile a quella dello Stato che parte dall’alto, allora deve innanzi tutto concentrarsi sulla persuasione verso un cambiamento di paradigma antropologico, così come infatti fa in modo convincente Federico Butera.
A tutta prima l’etica proposta appare ispirata al buon senso e alla moderazione. Sembra un’etica di piccolo cabotaggio poco adatta a contrastare la possanza del degrado ambientale che il libro ha illustrato sul piano scientifico. Ma non è così, perché l’attenzione per la cooperazione, la solidarietà, la condivisione e l’equità richiedono un cambiamento radicale di rotta nell’autocomprensione antropologica e nel modo d’intendere le relazioni sociali e politiche. Bisogna uscire dall’ideologia aggressiva del benessere consumistico ed esercitare quella virtù cardinale che gli antichi chiamavano “temperanza” e che oggi più adeguatamente (la temperanza è rivolta solo a se stesso) s’intende come una virtù sociale chiamata “sobrietà”. Questa è la virtù della complessità che tutti gli esseri viventi esercitano in modo istintivo e inconscio e che la specie umana deve assumere come scelta interiore e personale che si rende visibile nei comportamenti e negli stili di vita.
- Laudato si’, § 48
- Cfr. Horn e Bergthaller