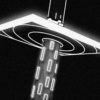Il testo è una risposta all’articolo di Massimiliano Palme Lo Zen e l’arte di raffrescare le città pubblicato su Connettere.
Confesso di sapere molto poco della dialettica fra cultura giapponese contemporanea e natura ma guardando lo skyline di Tokyo o di qualsiasi altra meno grande città giapponese, si fa molta fatica a vederne un esempio di integrazione con la natura. Se poi nel mezzo del frastuono, dell’inquinamento, della frenesia della città, qua e là c’è un’oasi di pace con un giardinetto pieno di piante curate, laghetti, pesci e ponticelli, non un sembra un gran segno di integrazione uomo-natura, non mi pare sia una grande dimostrazione di questa dialettica.
Ma forse mi sbaglio. Fatto è che questo tipo di “dialettica” mi ricorda molto da vicino quella che si sta sempre più affermando nel linguaggio dell’architettura quando si avvolgono gli edifici con un manto di verde (alberi o facciate o tetti che siano), sempre nel bel mezzo di uno skyline che cerca di competere con quello di New York o, in chiave più moderna e terrorizzante, con quello di Shanghai, sempre in mezzo ai PM 2,5 e ai PM 10 e al frastuono e alla frenesia.
Il problema è che di solito il rapporto fra la città e il verde è visto come qualcosa che riguarda l’isola di calore urbana, il comfort termico, la vivibilità, valori estetici, la qualità dell’aria, la capacità drenante del terreno, e così via. E va bene. Ma credo occorra andare oltre. Il dramma delle città di oggi è che funzionano in modo totalmente difforme da quelli che sono i principi con cui funzionano i sistemi naturali. L’attuale metabolismo urbano è un tritacarne di risorse di ogni genere, sfruttate solo in minima parte e per questo si riversano nell’ambiente grandissime quantità di rifiuti, di parti non digerite. È l’applicazione del modello economico-culturale corrente, centrato sul produci-usa-getta che ha governato e governa il nostro mondo in modo sempre più spasmodico a partire dall’inizio della cosiddetta “grande accelerazione”, ai primi anni ’50 del secolo scorso.
Allora, credo che la dialettica città-natura, tecnologia-natura, uomo-natura, chiamiamola come vogliamo, dovrebbe essere affrontata in termini di trasformazione del metabolismo urbano verso un modello capace di mimare il più possibile i sistemi naturali. Cioè, in definitiva, trasformare l’attuale modello lineare produci-usa-getta in un modello circolare, in cui tutti gli input (prodotti grezzi e finiti, acqua, cibo) siano usati e riusati il più possibile, spremendone tutte le potenzialità attraverso processi che abbiano come obiettivo la minimizzazione dei rifiuti.
Il verde urbano è parte di tutto questo, importantissima per le ragioni sopra elencate e altre, ma solo parte. Centrale invece è come valore didascalico, specie se del verde di corridoi ecologici si tratta, micro-ecosistemi i cui principi la città deve cercare di mimare e in essi integrarsi.
Ma i corridoi ecologici sono un artificio, necessario specialmente nei grandi conglomerati. Un centro abitato che voglia ripristinare il rapporto con la natura, nel senso accoglierne e applicare i principi di funzionamento, deve chiudere cicli non solo al suo interno, ma anche nel rapporto con l’esterno, con il territorio circostante, allo scopo di chiudere un ciclo importantissimo, quello dei nutrienti. I nutrienti che si trovano nel cibo che mangiamo e che metabolizziamo, e che sono poi riversati nei rifiuti organici che produciamo. Rifiuti che, diventati acque reflue, vengono trattati per renderli inoffensivi dal punto di vista sanitario e adatti per essere sversati nei corsi d’acqua senza creare (troppo) danno. Ma questi nutrienti, quelli che abbiamo metabolizzato, provengono dal suolo, assorbiti dai prodotti agricoli che abbiamo mangiato e, per produrre altro cibo, occorre rifornire il suolo di altri nutrienti; e glieli forniamo, artificiali. Così, da una parte produciamo (con tutto l’impatto ambientale associato) i nutrienti, fertilizzanti artificiali, e dall’altra li raccogliamo, li trattiamo e li buttiamo, invece di riportarli nei campi, come si potrebbe fare, magari riuscendo anche a produrre una certa quantità di biogas.
Ma fare questa operazione efficacemente, cioè trattare le acque reflue in modo da recuperarne i nutrienti, opportunamente trattarli e restituirli ai terreni da cui provengono, occorre che i centri abitati non siano troppo grandi, non fosse altro per motivi logistici, e quindi anche di costo.
Allora, si potrà pure avere voglia di stare a New York invece che a Boston, o a Roma piuttosto che a Viterbo, ma non si pretenda di far credere che Central Park contribuisca alla circolarità del metabolismo della città, che l’aiuti a mimare la natura, almeno per come è oggi concepito, senza per questo sminuirne tutti gli altri valori che certamente ha.