Un articolo dell’Economist sulla perdita di competizione nel capitalismo contemporaneo, inizia così:
Una luminosa mattina all’inizio dell’anno il vostro corrispondente si è recato da New York all’Università di Chicago per partecipare a una conferenza sulla minaccia alla prosperità rappresentata dai monopoli. Il viaggio è iniziato con un allarme acustico su un telefono prodotto da Apple (che ha una quota di mercato del 62% in America), poi una corsa in taxi verso l’aeroporto pagata usando di un pezzo di plastica rilasciato da una delle tre società, American Express , MasterCard e Visa, che controllano il 95% del mercato delle carte di credito. Nel terminal, la colazione è fornita da una famosa catena di fast-food, mentre le e-mail sono state controllate usando Google, che ha il 60% del mercato dei browser.
Il segnale dello smartphone è stato trasmesso su una delle tre reti che controllano il 78% del mercato delle telecomunicazioni. Il volo era con una delle quattro compagnie aeree che controllano il 69% dei viaggi all’interno dell’America. A Chicago il vostro corrispondente è entrato nell’hotel LondonHouse, che sembra una boutique ma risulta essere parte dell’Hilton, che controlla il 12% di tutte le camere in America e il 25% delle nuove camere in costruzione. La prenotazione è stata effettuata su Expedia, che ha il 27% del mercato dei viaggi online in Nord America.
Le imprese coinvolte nel viaggio hanno realizzato profitti per $ 151 miliardi e hanno avuto un rendimento medio del capitale del 29% lo scorso anno. Un paniere ugualmente ponderato delle loro azioni – lo chiamano il portafoglio monetario monopolistico – ha battuto il mercato azionario globale del 484% negli ultimi dieci anni. Complessivamente, il 17% delle azioni delle società è di proprietà di soli tre mega-manager di investimento, BlackRock, Vanguard e State Street.
L’articolo è centrato sul fatto che l’esistenza di poche, grandi, aziende frena la competizione, e la competizione è alla base dello sviluppo economico, secondo i principi vigenti dell’economia.
Proviamo a parlarne, allora, di queste corporation, di queste grandi imprese multinazionali. Si tratta di imprese, ricordiamolo, la cui unica finalità, per statuto, è quella di generare profitti per gli azionisti, il più possibile e a qualunque costo, indifferenti a qualsiasi considerazione etica o ambientale (quest’ultima parte non sta nello statuto, ma ne è la conseguenza pratica). Per perseguire questo fine controllano i prezzi dei prodotti e delle materie prime necessarie per produrli, procurandosele nei paesi in via di sviluppo, ricchi di risorse e facilmente corruttibili (altro che prezzi determinati dall’equilibrio fra domanda e offerta, come recita l’economia classica); utilizzano la forza lavoro a basso costo dei paesi più poveri per minimizzare i costi di produzione; inondano di pubblicità i consumatori, creando la domanda dei beni che producono attraverso la induzione di nuovi bisogni; governano i flussi finanziari all’estero e dall’estero; esercitano forti azioni di lobbying per ottenere vantaggi sul piano delle regole della competizione; fanno un aggressivo ricorso al prestito per amplificare la portata degli investimenti dei propri azionisti; sono aziende troppo grandi per fallire (diceva Keynes: se ti devo una sterlina, ho un problema; ma se ti devo un milione di sterline, il problema è tuo), e sono quindi in grado di scaricare sulla società gli enormi costi delle crisi finanziarie originate dal loro indebitamento.
In un contesto del genere il destino di tante piccole e medie imprese è segnato, e più difficile è l’introduzione di nuovi prodotti competitivi ed innovativi; e quando ciò avviene, solitamente la piccola impresa viene acquistata dalle corporation con un’offerta che non si può rifiutare.
Giusto per avere un’idea della dimensione di alcune corporation, oltre a quelle citate nell’articolo dell’Economist, e con le quali ciascuno di noi ha o ha avuto a che fare, basti pensare che, a scala mondiale:
- 10 aziende controllano il 70% del mercato degli elettrodomestici
- 5 aziende controllano il 70% del mercato automobilistico
- 5 aziende controllano il 70% del mercato dei PC
- 4 aziende controllano circa il 50% del mercato degli smartphone
- 1 azienda controlla oltre il 70% del mercato dei social media.
La crescita delle corporation va a braccetto con la globalizzazione, di cui esse fanno da apripista e in cui giocano un ruolo centrale. La globalizzazione, che in astratto potrebbe non essere una cattiva idea, in realtà è stata messa in atto in modo inaccettabile, come osserva Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia, perché:
- Le regole del gioco che governano la globalizzazione sono inique e tendono a favorire i paesi industrializzati.
- La globalizzazione antepone valori materiali ad altri valori, come per esempio la tutela dell’ambiente o della vita stessa.
- Benché i fautori della globalizzazione sostengano che tutti ne avrebbero tratto un vantaggio economico, è dimostrato che molti ci hanno rimesso, sia nei paesi ricchi sia quelli poveri.
D’altra parte, a favore della globalizzazione di solito si porta il miglioramento delle condizioni economiche dei paesi in cui è stata delocalizzata la produzione. Vero, in alcuni casi, se per condizioni economiche del paese si intende aumento del PIL; peccato che questo aumento abbia esacerbato le già gravi condizioni di disuguaglianza preesistenti. Il grosso dell’incremento del PIL è andato a gonfiare le tasche di pochi, lasciando invariata, e in moltissimi casi peggiorando la condizione dei più. Ciò è dimostrato dal fatto che di tutta la ricchezza globale creata nel 2017, l’82% è andato all’1% della popolazione mentre il 50% meno abbiente non ha beneficiato di alcun aumento, e che questo 1% più ricco possiede più ricchezze di tutto il resto dell’umanità.
La globalizzazione, infatti, così come è stata gestita, ha aumentato la disuguaglianza sia nei paesi ricchi che in quelli poveri e si è trasformata in una nuova, più insidiosa, forma di colonialismo, sfruttando le risorse umane e naturali dei paesi più poveri e deboli.
Il rapporto sinergico fra globalizzazione e corporation multinazionali si esplicita in modo esemplare nell’agricoltura, a danno dei piccoli coltivatori, sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli sviluppati. Le aziende che vendono sementi, fertilizzanti e diserbanti ai piccoli contadini hanno finito per imprigionarli in una spirale di dipendenza economica che nella maggior parte dei casi li ha portati a condizioni peggiori di quelle di partenza, quando le loro tecniche di coltivazione erano quelle tradizionali, e la produttività era più bassa. D’altra parte, si fa osservare, grazie alle sementi selezionate, ai fertilizzanti artificiali, ai diserbanti e ai pesticidi, la produzione agricola globale è aumentata considerevolmente, permettendo di sfamare in un modo o nell’altro la crescente popolazione mondiale, che si va sempre più urbanizzando. Questo è vero, ma a che prezzo, e fino a quando? E il prezzo non è solo quello che pagano i piccoli agricoltori, è anche quello che paghiamo tutti attraverso l’inquinamento dei terreni e delle acque, le emissioni di gas di serra, la distruzione degli ecosistemi, lo sfruttamento insensato del capitale naturale. Ancora una volta, e su scala planetaria, viene messa in atto la socializzazione delle perdite e la privatizzazione (a favore di pochissimi) dei profitti.
Altissima è la concentrazione del potere economico e lobbystico delle multinazionali dell’agricoltura. Per averne un’idea basta dare uno sguardo ai seguenti dati:
- 8 aziende controllano il 65% della produzione di fertilizzante (il 40% la sola Mosaic)
- 7 aziende producono il 65% dei semi (il 35% la sola Monsanto)
- 3 aziende controllano il 63% del mercato commerciale dei semi
- 5 aziende controllano il 70% del mercato dei prodotti agrochimici
- 4 aziende controllano il 90% del commercio mondiale di grano
Come se non bastasse, a scala mondiale, l’1% delle aziende agricole possiede il 65% di tutti i terreni destinati all’agricoltura. Un processo di concentrazione della proprietà che da qualche tempo è in corso di accelerazione mediante l’accaparramento di vasti territori (land grabbing) nei paesi in via di sviluppo, principalmente in Africa.
Lo sfruttamento dei poveri dei paesi in via di sviluppo è un elemento caratterizzante dell’arricchimento delle multinazionali, direttamente o indirettamente. Direttamente, quando li impiegano con salari di fame nell’industria manifatturiera delocalizzata e nell’agricoltura locale per quelle fasi che non conviene meccanizzare. Indirettamente, nei paesi industrializzati stessi, quando le multinazionali “esternalizzano” alcune fasi del processo produttivo affidandole a imprenditori senza scrupoli che ingaggiano gli immigrati, spesso clandestini, che vengono sottopagati, quanto nei paesi di origine più o meno. Tipici esempi, come alcuni servizi giornalistici hanno denunciato in Italia, sono quegli immigrati che in bui e nascosti sotterranei cuciono magliette e jeans di marchi famosi, o quelli che, nei loro tuguri, ripuliscono dalle sbavature le guarnizioni che poi andranno nelle nostre automobili di lusso, o quelli che, accampati in rifugi di fortuna, raccolgono il pomodoro nelle campagne del sud, loro che prima raccoglievano il proprio, nelle loro terre.
Come si è potuto permettere che tutto ciò avvenisse? Semplice: è l’inevitabile prodotto del modello economico imperante (quello che l’Economist dice essere messo in difficoltà dalla mancanza di competizione). È stato il modello economico a generare inevitabilmente la concentrazione delle attività produttive nelle mani delle corporation, che hanno forgiato la globalizzazione nella forma in cui si presenta oggi, e lo stesso modello ha forgiato il modo di operare delle imprese di qualsiasi dimensione, tutte ossessionate da un solo indicatore di successo: la crescita. Tutte si nutrono da una parte del consumismo che promuovono con ogni mezzo perché è alla base della loro esistenza e della loro crescita e dall’altra dello sfruttamento dissennato delle risorse naturali. Il risultato è una crescente disuguaglianza e la alterazione degli equilibri naturali che sono alla base della nostra stessa esistenza. Una tempesta perfetta che, andando alla radice, deriva dal considerare l’uomo solo come un avido accumulatore di denaro, senza altri valori e senza altre soddisfazioni che vadano oltre il proprio conto in banca, e dal ritenere che non esistano limiti alla crescita. Questo è l’Homo Oeconomicus, l’uomo su cui il modello economico si fonda. Un uomo con il quale nessun essere umano degno di questo nome dovrebbe accettare di essere identificato.
Data la dimensione del problema sembrerebbe che siamo impotenti e dobbiamo necessariamente subire, come un tempo subivano i servi della gleba. Non è così, invece. Possiamo fare qualcosa. Possiamo, per esempio, rifiutarci di farci coinvolgere in eventi come il Black Friday, una trovata che, a pensarci bene, umilia la nostra condizione di uomini, trattandoci come mucche da mungere, e pure sceme. Possiamo comprare arance prodotte a dieci chilometri di distanza invece di ananas prodotti a diecimila; possiamo continuare ad usare una maglietta anche se “non si usa più”; possiamo comprare solo scarpe riparabili; possiamo comprare il più possibile nel negozietto sotto casa invece che nel centro commerciale, pensando quanto risparmiamo in benzina, ammortamento auto e tempo; e così via. Possiamo, dobbiamo riflettere tutte le volte che compriamo un bene o un servizio, e domandarci: l’acquisto serve più a me o a chi lo produce? Che danno faccio all’ambiente, cioè ai miei figli e nipoti, con quell’acquisto?
Ecco cosa possiamo, dobbiamo fare. Ma soprattutto dobbiamo esercitare la massima pressione sulla classe politica affinché svolga il suo mandato a favore nostro e del pianeta, e non a favore di quei pochi che governano le multinazionali, come ha fatto finora.
In altre parole, proviamo a ribellarci.


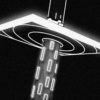







Articolo lucidissimo, circostanziato e provocatorio, come nello stile dello stimato Prof. Butera.
Liberarsi dalla vorticosa spirale consumistica globalizzata può sembrare utopistico ma rappresenta oggi l’unica vera forma di rivoluzione.
Rivoluzione che non può non partire dalle proprie piccoli grandi scelte quotidiane, come insegnava, con un certo successo, il Mahatma Gandhi. Tendendo a quella conversione ecologica integrale sapientemente descritta e invocata nella Laudato Si’ dal più grande rivoluzionario dei nostri tempi.