Racconta un inviato del New York Times: Una mattina presto, sulle rive di un ruscello asciutto, con l’aria che sa di fuliggine e sabbia, la signora Tede sta producendo carbonella. Lei, una stecca di donna senza età, dice che una volta aveva 200 capre, abbastanza da vendere alcuni dei nuovi nati al mercato e comprare farina di mais per la sua famiglia. L’allevamento del bestiame è tradizionalmente la principale fonte di reddito nella regione, poiché qui non cresce molto cibo.
Molte delle sue capre sono morte durante la siccità del 2011, poi molte altre nella siccità del 2017. Quante ne sono rimaste? Ha alzato cinque dita. Non abbastanza da vendere. Non abbastanza da mangiare. E ora, nella stagione secca, neanche abbastanza da prendere il latte. “Solo quando piove ne prendo una o due tazze, per i bambini”, dice.
La siccità più recente ha spinto alcuni pastori a saccheggiare il bestiame delle comunità rivali o a nascondersi nelle riserve naturali per pascolare gli animali affamati. L’acqua è diventata così scarsa in questa vasta contea – conosciuta come Turkana, nel nord-ovest del Kenya – che raccoglierla, che è il lavoro delle donne, significa camminare in media più di dieci chilometri al giorno.
La signora Tede ora raccoglie la legna per fare il carbone, un processo che sta spogliando la terra dei suoi pochi alberi, così che quando arrivano le piogge, se arrivano le piogge, l’acqua non si infiltrerà nella terra. Sul ciglio della strada c’erano quelli che un tempo erano i sacchi degli aiuti alimentari, ora imbottiti di carbone, in attesa di clienti.
Più avanti lungo la stessa strada, in un villaggio benedetto da una pompa d’acqua, un pastore di nome Mohammed Loshani ha raccontato la sua situazione. Da 150 capre poco più di un anno fa, ne sono rimaste 30. Durante la siccità del 2017, il primo mese ne morirono 10, una dozzina quello dopo, e così via.
“Se piove, posso ricostruire la mia mandria”, ha detto. “Altrimenti, anche le poche che ho moriranno. Se questi periodi di siccità continuano non c’è niente da fare per noi. Dovremo pensare ad altri lavori”. O a migrare, possiamo aggiungere.
Si prevede che i cambiamenti climatici nel XXI secolo costringeranno sempre più persone a migrare, per molte ragioni.
Una ovvia relazione diretta fra cambiamento climatico e migrazioni si ha nel caso di eventi meteorologici estremi, come alluvioni, uragani, incendi, per cui la gente perde tutto e non ha altra soluzione che cercare fortuna da qualche altra parte. Generalmente si tratta di migrazioni temporanee.
Un’altra relazione diretta c’è con l’innalzamento del livello del mare. Con 0,5 m di innalzamento entro il 2100, infatti, 0,877 milioni di km2 di territorio finirebbero sott’acqua, provocando l’esodo di 72 milioni di persone; con una variazione del livello del mare di 2,0 m, la superficie sommersa diventerebbe 1,778 milioni di km2, e l’esodo coinvolgerebbe 187 milioni di persone, pari al 2,4% della popolazione mondiale.
Un’altra causa, meglio concausa, delle migrazioni sono i cambiamenti ambientali sul lungo termine, strutturali, quale la riduzione della produzione agricola a causa dell’aumento della temperatura e di siccità prolungate: c’è sempre meno da mangiare e chi può cerca di andare dove spera ci siano migliori possibilità. Sono concause perché molti sono i fattori che possono indurre a migrare: conflitti armati, problemi economici, politici ed etnici, che spesso sono esacerbati o innescati dai cambiamenti climatici; la migrazione è un fenomeno multi-casuale, in cui il cambiamento climatico agisce come fattore di amplificazione.
Le migrazioni favorite dal cambiamento climatico sono già una realtà oggi. Dal 2012 al 2016, gli sfollati a causa di conflitti sono stati 41 milioni, e quelli a causa di disastri naturali legati a fattori meteorologici 117 milioni. In media negli ultimi anni 26,4 milioni di persone ogni anno sono state costrette ad abbandonare la loro terra a causa di disastri naturali; questo è equivalente a una persona ogni secondo. Sulla base di questi dati, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) stima 200 milioni di “migranti ambientali” entro il 2050, ma altre stime arrivano fino a 700 milioni.
In questo quadro è bene non dimenticare che le principali vittime delle migrazioni sono i bambini, più deboli sia psicologicamente che fisicamente.
I mezzi di comunicazione dei paesi sviluppati ci danno l’impressione che coloro i quali migrano lo facciano col solo scopo di raggiungere l’Europa, o gli USA, in cui farsi una nuova vita. In realtà i migranti che raggiungono i confini di un paese sviluppato rappresentano solo una piccola parte della quantità totale di flussi migratori in tutto il mondo: la maggior parte delle quali avviene all’interno dei confini nazionali, dalle aree rurali alle città e ai centri urbani. Per esempio, ogni anno circa 12 milioni di persone attraversano i confini dell’Africa occidentale e centrale, ma la stragrande maggioranza di questi migranti non sta cercando di arrivare in Europa. Più del 75% di loro si sposta all’interno dell’Africa sub sahariana, passando da un paese all’altro, sia per opportunità economiche sia in fuga da conflitti.
Il cambiamento climatico da solo non causa conflitti, ma può agire come un acceleratore di instabilità o conflitto, poiché influenza la distribuzione e la disponibilità di risorse naturali critiche, determina condizioni di insicurezza alimentare, e può agire come un “moltiplicatore di minacce” provocando migrazioni di massa e condizioni esacerbanti che possono portare a disordini sociali e conflitti armati.
Una risorsa fortemente influenzata dal cambiamento climatico è l’acqua. Secondo il XXIV Rapporto Immigrazione 2014 di Caritas e Migrantes, edito da Tau Editrice Srl, “ci sono 145 nazioni nel mondo che devono condividere le proprie risorse idriche con altri paesi, ovvero utilizzano bacini idrici internazionali, che nel mondo sono ben 263. Negli ultimi cinquant’anni, la condivisione di questi bacini è stata causa di 37 conflitti violenti. La domanda di acqua sta raggiungendo i limiti della disponibilità, resa più critica dai cambiamenti climatici, e quindi aumenta il rischio di confronti armati tra i paesi che condividono le proprie riserve idriche. Oltre cinquanta di loro, nei prossimi anni potrebbero entrare in dispute violente sulla gestione di laghi, fiumi, dighe e acque sotterranee”.
Il caso più drammatico che si è registrato finora è la guerra in Siria. Secondo uno studio pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences, “ci sono prove che la siccità 2007-2010 ha contribuito al conflitto in Siria”.
Tre anni di piogge scarse hanno provocato una drastica riduzione dell’acqua che si poteva pompare dal sottosuolo. Questa limitazione, accompagnata da una cattiva gestione delle risorse idriche, e una errata gestione politica degli eventi hanno portato a un forte aumento dei prezzi dei generi alimentari. Tutto ciò, unito al peggioramento delle condizioni economiche del paese, ha portato un gran numero di famiglie di agricoltori a migrare verso aree urbane. Il rapido aumento della popolazione urbana da 8,9 milioni nel 2002 a 13,8 milioni nel 2010 ha messo sotto pressione le infrastrutture, le risorse economiche e i servizi sociali delle città; cosa che fu trascurata dal governo di Assad. Un brodo di coltura ideale per l’instabilità politica.
Attingendo da archeologia, criminologia, economia, geografia, storia, scienze politiche e psicologia, uno studio ha valutato l’entità dell’influenza del clima sulla conflittualità, ed è risultato che è sostanziale: per ogni variazione di 1 °C verso temperature più alte le stime medie indicano che la frequenza della violenza interpersonale aumenta del 4% e la frequenza del conflitto tra gruppi aumenta del 14%.
Una delle principali cause di conflitto, storicamente, sono state le crisi alimentari. Mentre la crescita economica riduce la probabilità e l’intensità di un conflitto armato, l’insufficienza della produzione alimentare con conseguente sotto-nutrizione è una delle più importanti e significative cause scatenanti. La fame, infatti, scatena guerre e rivoluzioni, che a loro volta producono fame, e alimentano altre crisi politiche e altra fame, in un ciclo apparentemente senza fine. Ogni volta che c’è una scelta tra morire di fame e invadere altri territori, l’uomo invade.
Ci sono evidenze scientifiche secondo cui nelle economie dipendenti dall’agricoltura irrigata con acqua piovana e dall’allevamento tanto l’aumento quanto la diminuzione delle precipitazioni fa crescere il rischio di conflitti violenti localizzati, in particolare nelle società pastorali in Africa. Per questo si ritiene che il cambiamento climatico abbia dato un contributo non irrilevante ai genocidi nella regione del Darfur iniziate nel 2003.
Non è solo il Corno d’Africa ad essere vittima di conflitti esacerbati dal cambiamento climatico; una situazione molto critica si è venuta a creare nella parte centrale della Nigeria, dove è in atto un conflitto fra mandriani nomadi e contadini sedentari che sta scatenando una crescente ondata di violenza. Sebbene il conflitto tra pastori e agricoltori risalga a secoli fa, si è acutizzato a causa del cambiamento climatico che, attraverso la riduzione della piovosità, spinge i pastori a sud. Gli scontri sono anche più letali grazie alle armi rubate dagli arsenali dell’ex dittatore libico, Muammar Gheddafi, e contrabbandati nella regione.
È evidente che non sono certo i muri o i porti chiusi la strada giusta per affrontare il problema delle migrazioni, e nemmeno le classiche formule della cooperazione o degli aiuti umanitari. Bisogna ripristinare e proteggere le condizioni ambientali che garantiscano l’accesso alle risorse primarie, cibo ed acqua, innanzitutto.
Peccato che molti tra i decisori politici, italiani, europei, nord-americani, non sembrano comprendere i motivi che spingono la gente a migrare. Possiamo mai tenerci gente così a decidere del nostro destino?


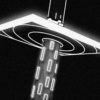







Parole lucide, accorate e circostanziate, come nel tuo stile, caro Prof. Butera.
Impossibile dissentire. Più facile associarsi per un attimo all’indignazione e poi scrollare le spalle, cedendo a un sentimento di impotenza di fronte a problemi di tale ampiezza e complessità.
Invece no, è doveroso parlarne, approfondire, connettere appunto, e diffondere. Alzare la voce, nella speranza che diventi un coro, capace di orientare alcune concrete scelte politiche. Sperando in persone che sappiano interpretare la politica come esercizio di responsabilità per le prossime generazioni, non solo in funzione delle prossime elezioni, o peggio dell’ultimo sondaggio.
Che ne direste di scrivere una lettera sul tema (anche in lingua inglese), una sorta di appello, e promuoverne la sottoscrizione a tutti i livelli? Potremmo suscitare attenzione e ottenere anche un certo sostegno “grassroots”.
Aspirando perfino all’endorsement da parte del più credibile e coraggioso profeta dei nostri tempi. Che la pensa esattamente come noi.
“I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche, e costituiscono una delle principali sfide attuali per l’umanità. Gli impatti più pesanti probabilmente ricadranno nei prossimi decenni sui Paesi in via di sviluppo. Molti poveri vivono in luoghi particolarmente colpiti da fenomeni connessi al riscaldamento, e i loro mezzi di sostentamento dipendono fortemente dalle riserve naturali e dai cosiddetti servizi dell’ecosistema, come l’agricoltura, la pesca e le risorse forestali. Non hanno altre disponibilità economiche e altre risorse che permettano loro di adattarsi agli impatti climatici o di far fronte a situazioni catastrofiche, e hanno poco accesso a servizi sociali e di tutela. Per esempio, i cambiamenti climatici danno origine a migrazioni di animali e vegetali che non sempre possono adattarsi, e questo a sua volta intacca le risorse produttive dei più poveri, i quali pure si vedono obbligati a migrare con grande incertezza sul futuro della loro vita e dei loro figli. È tragico l’aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa. Purtroppo c’è una generale indifferenza di fronte a queste tragedie, che accadono tuttora in diverse parti del mondo. La mancanza di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle è un segno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile.”
dall’Enciclica di Papa Francesco LAUDATO Si’ – SULLA CURA DELLA CASA COMUNE
Parole lucide, accorate e circostanziate, come nel tuo stile, caro Prof. Butera.
Impossibile dissentire. Più facile associarsi per un attimo all’indignazione e poi scrollare le spalle, cedendo a un sentimento di impotenza di fronte a problemi di tale ampiezza e complessità.
Invece no, è doveroso parlarne, approfondire, aggiornare, diffondere. Alzare la voce, nella speranza che diventi un coro, capace di orientare alcune concrete scelte politiche. Sperando in persone che sappiano interpretare la politica come esercizio di responsabilità per le prossime generazioni, non solo in funzione delle prossime elezioni, o peggio dell’ultimo sondaggio.
Che ne dici di scrivere una lettera sul tema (anche in inglese) e promuoverne la sottoscrizione a tutti i livelli? Potremmo suscitare attenzione e consenso “grassroots”.
Aspirarando perfino al sostegno del più coraggioso profeta dei nostri tempi. Che la pensa esattamente come noi.
“I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche, e costituiscono una delle principali sfide attuali per l’umanità. Gli impatti più pesanti probabilmente ricadranno nei prossimi decenni sui Paesi in via di sviluppo. Molti poveri vivono in luoghi particolarmente colpiti da fenomeni connessi al riscaldamento, e i loro mezzi di sostentamento dipendono fortemente dalle riserve naturali e dai cosiddetti servizi dell’ecosistema, come l’agricoltura, la pesca e le risorse forestali. Non hanno altre disponibilità economiche e altre risorse che permettano loro di adattarsi agli impatti climatici o di far fronte a situazioni catastrofiche, e hanno poco accesso a servizi sociali e di tutela. Per esempio, i cambiamenti climatici danno origine a migrazioni di animali e vegetali che non sempre possono adattarsi, e questo a sua volta intacca le risorse produttive dei più poveri, i quali pure si vedono obbligati a migrare con grande incertezza sul futuro della loro vita e dei loro figli. È tragico l’aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa. Purtroppo c’è una generale indifferenza di fronte a queste tragedie, che accadono tuttora in diverse parti del mondo. La mancanza di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle è un segno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile.”
dall’Enciclica di Papa Francesco LAUDATO Si’ – SULLA CURA DELLA CASA COMUNE
Chissà se qualcuno sta facendo ricerche per intervenire sul clima con operazioni in ambientali a breve termine: far piovere ad esempio, perchè come diceva Keynes …” on the long term we will be all dead…”
Bellissimo articolo: attuale, crudo e reale.
Purtroppo sembra non ci sia veramente speranza per l’antropocene.
Domani (20 luglio) sull’inserto domenicale del Corriere della Sera ci sarà un approfondimento sugli effetti del cambiamento climatico. Potrebbe essere interessante.